"I ferraresi di una certa età ricordano più il giardino che il museo".
Parola di due estensi doc, Mario Resca, classe 1945, Direttore Generale per la
valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, e Carla Di Francesco, Direttore Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell'Emilia-Romagna. Di quando, bambini, ci venivano in gita
scolastica, ricordano le vetrine, certo, i reperti, gli stucchi e le preziose
ceramiche attiche: ma il ricordo più vivido è per il giardino del museo, con le
sue siepi, il roseto, il vasto labirinto.
Con il passare del tempo, la penuria di fondi ha portato al collasso l’unico
esempio compiuto di giardino formale storico superstite a Ferrara. Ora un
progetto di restauro di elevatissimo livello culturale porterà
a nuova vita il giardino di Palazzo Costabili, contribuendo a far vivere al
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara quel secondo Rinascimento già iniziato
nel 2007 con l'ampliamento espositivo, l'apertura di molte nuove
sale, il restauro della Sala del Tesoro affrescata dal Garofalo e la riapertura
della Sala delle Monossili (piroghe).
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna
ha pianificato un intervento finalizzato ad una valorizzazione degli spazi verdi
del museo che permetta, oltre che un restauro dei valori storici e formali,
anche una ottimizzazione delle risorse di manutenzione. I lavori di restauro, iniziati nell'agosto 2009,
si sono conclusi entro la fine dell'anno:
la spesa si aggira sui 300mila euro interamente finanziati dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali grazie all'utilizzo di una parte
dei Fondi Lotto 2004-2006.
Il 18 giugno 2010 il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara si
riapproprierà dei suoi Giardini, per anni preclusi al godimento dei visitatori e
della cittadinanza e finalmente restaurati grazie ad un accurato intervento di
restauro.

Una suggestiva immagine del giardino di Palazzo Costabili di gusto
neo-rinascimentale. Al centro, il labirinto aggiunto negli anni '50
Il Giardino di Palazzo Costabili, quello attuale a mezzogiorno, costituisce
l’unico esempio compiuto di giardino formale storico superstite a Ferrara. Non
si tratta, in realtà, dell’originale giardino rinascimentale ma di una
simulazione, un esercizio di stile realizzato negli anni Trenta, in occasione
dei lavori di restauro del complesso, in un’area che corrispondeva in parte con
gli antichi orti del Palazzo.
Il giardino di rappresentanza vero e proprio era invece situato lungo la Via
della Ghiara, a levante del Palazzo Costabili. Di questo giardino non rimane che
un piccolo brandello e la memoria storica, testimoniata dai documenti e da
vedute antiche.
Il giardino di mezzogiorno ha subito, soprattutto negli anni cinquanta, numerosi
interventi e l’impianto di specie arboree e arbustive incongrue, dettato più da
mode e gusti del momento che da un vero progetto.
Lo stato dell’impiantistica era obsoleto, la necessità di grandi manutenzioni
non era commisurata alle risorse umane del Museo ed alcuni alberi avevano
mostrato preoccupanti segni di degrado.
Per questi motivi la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna ha deciso di utilizzare parte dei Fondi Lotto 2004-2006 per
un intervento finalizzato ad una valorizzazione degli spazi verdi del museo che
ha permesso, oltre che un restauro dei valori storici e formali, anche una
ottimizzazione delle risorse di manutenzione.
Sono state effettuate indagini a tappeto affinché tutta l’operazione potesse
contare su un quadro conoscitivo preciso e dettagliato.
Indagini archeobotaniche e palinologiche hanno restituito interessanti dati
sulle specie vegetali presenti nell’area nel corso dei secoli; studi agronomici
condotti grazie ad una convenzione di collaborazione con il Comune di Ferrara,
hanno consentito di ricostruire un quadro completo dello stato vegetazionale e
agronomico; saggi archeologici hanno restituito nuovi importanti dati e conferme
sulle strutture antiche e sugli impianti storici.
L’intervento ha raccolto i dati di studio e ha permesso un restauro di elevato
livello culturale che ha finalmente portato i giardini a nuova vita, mantenendo
la sua impostazione storicizzata, i percorsi geometrici con le siepi di bosso,
il labirinto, il pergolato di rose, il fondale coi monumentali cedri del Libano.
Anche il Giardino di Levante, ciò che resta dell’antico, splendido giardino
rinascimentale, è stato anch’esso oggetto di restauro e ospita adesso al proprio
interno uno spazio in cui esporre i segnali tombali rinvenuti nella necropoli di
Spina, costituiti da elementi lapidei provenienti da tutto il bacino del
mediterraneo. Questa esposizione servirà anche per testimoniare le rotte
commerciali dell’emporio spinetico.
Dati tecnici
Inquadramento
Il progetto è stato elaborato dall’architetto Maria Luisa Mutschlechner con
la collaborazione di molti specialisti e con il contributo dello Studio
Associato Pangea di Padova.
Ha partecipato alla fase preliminare di valutazioni e rilevi agronomici il
Comune di Ferrara nominando l’agronomo Giovanni Morelli – Studio Associato
PROGETTO VERDE .
Sono state effettuate approfondite ricerche storiche e d’archivio con la
collaborazione dell’Architetto Caterina Tantillo, nell’ambito di una convenzione
di ricerca con l’Università di Roma la Sapienza, ed una serie di sondaggi, per
quanto riguarda le indagini archeologiche nel giardino, realizzati dalla
Cooperativa La Fenice –Archeologia e Restauro. Al fine di comprendere l’uso dei
terreni nei secoli scorsi e risalire alle piante un tempo a dimora nel giardino
sono state effettuate delle analisi palinologiche riferite al periodo tra il XV
ed il XVI secolo coordinate dalla Dott.ssa Silvia Marvelli del centro C.A.A.
Nicoli di san Giovanni in Persiceto.
Il notevole lavoro di studi, ricerche, indagini ed analisi, indispensabile per
un intervento di restauro, ha restituito un quadro esaustivo della storia e
dello sviluppo del giardino.
Del giardino rinascimentale vero e proprio non rimane traccia. Dall’iconografia
storica si può desumere che si estendeva ad est del Palazzo insieme con una
stalla ed alcune fabbriche.
Dalle indagini archeologiche è emerso che nell’attuale giardino a sud vi era un
muro di cinta che tagliava trasversalmente il giardino con una porta di accesso
all’area esterna che era coltivata ad orto - frutteto. Tale muro è stato
demolito verso la metà del 1800. La destinazione d’uso ad orto è rimasta
invariata fino all’inizio del ‘900.
Verso gli anni ’30, in occasione del restauro del Museo, si procedette al
ridisegno dei giardini di mezzogiorno e di levante, con una ricostruzione
immaginaria di un giardino rinascimentale. Il disegno redatto dal disegnatore
tecnico Stanzani, che non si basava sulle preesistenze ma era frutto di
un’invenzione grafica, applicava con buona volontà le direttive che provenivano
dai dettami ministeriali sulla riproposizione del giardino rinascimentale
ferrarese.
Nel 1939 il giardino si presentava come una semplice compartimentazione a
riquadri che delineava le aiole contornate da bosso e ligustro e manteneva le
direttrici dei percorsi ancora oggi esistenti, sia ad est che a sud. La
prospettiva dei percorsi si concludeva con esedre curve di ligustro che
occludevano la vista.
I giardini, al momento dell’avvio dei lavori di restauro, si presentavano come
il risultato dell’intervento degli anni ’30 e di una serie successiva di
integrazioni e di iniziative spontanee e non coerenti.
Il labirinto e gli altri disegni di bosso sono stati aggiunti dopo gli anni ’50,
all’interno dei riquadri inizialmente vuoti; successivamente sono stati aggiunti
i Cupressus Arizonica, i Tassi, le Thuie, i Cercis, Robinie, gli Abeti ed è
stata realizzata la galleria delle rose.
Col passare degli anni si è così perso il disegno del giardino formale e a
favore di un sovraffollamento disordinato di arbusti ed alberature che
presupponeva una sempre maggiore necessità di manutenzione.
L’intervento
Il risultato di una evoluzione del giardino non programmata e coordinata ha
portato alla necessità di un urgente ed articolato intervento di riordino, non
solo di tipo formale ed estetico ma anche funzionale a ragioni di sicurezza e di
pubblica incolumità.
Una sempre più scarsa manutenzione del giardino aveva, infatti, definitivamente
messo in crisi il sistema, innescando un meccanismo di autodistruzione.
L’intervento effettuato è consistito in realtà in una manutenzione conservativa,
che ha tenuto conto sia dei dati archeologici rinvenuti sia delle conseguenze
dei restauri congetturali degli anni Trenta e delle modifiche successive.
E’ stata mantenuta la struttura ed il disegno delle siepi, dei percorsi ed anche
di alcuni elementi aggiunti come il labirinto e la galleria di rose perché
fortemente elementi caratterizzanti il giardino.
I Cedri Deodara e del Libano, che si trovano verso il confine sud, sono stati
oggetto di un intervento di rimonda del secco e di innalzamento della chioma.
Il labirinto e, in generale, tutte le siepi in bosso sono state oggetto di
interventi puntuali di ricucitura mediante integrazione e sostituzione delle
fallanze.
I quattro tassi sono stati riposizionati al centro dei riquadri oltre il pozzo
per non interferire con la vista prospettica dal portico d’entrata, con la
lettura del disegno delle siepi e per la tutela delle strutture archeologiche
rinvenute tra gli 80 e 100 cm di profondità.
Al centro dei riquadri delle siepi laterali, le preesistenti piante di Thuia ed
una Magnolia sono state sostituite con due alberi di Melograno, pianta già
presente nel giardino, molto utilizzata nel corso del rinascimento e
rappresentata nelle decorazioni della Sala del Tesoro del Garofalo.
Le aiole sono state rimodellate e all'interno dei riquadri sono state piantate
specie erbacee, tappezzanti e bulbose fiorite per creare una copertura stabile e
non invasiva del piano sottostante. Si è scelto di mettere a dimora specie con
radici superficiali con per creare superfici cromaticamente uniformi e fiorite,
che sottolineino con la loro diversità il disegno delle siepi.
Il muro di cinta è stato rivestito con piante rampicanti fiorite quali: Rose,
Hydrangee, Clematis armandii, e viti americane che cresceranno su idonei
grigliati in ferro.
E’ stato infine di realizzato un impianto di illuminazione.

Ferrara. Palazzo Costabili, sede del Museo Archeologico Nazionale. Il giardino
prima dell'avvio dei lavori di restauro
18 settembre 2009 - Presentazione del progetto
di valorizzazione degli spazi verdi di Palazzo Costabili
Comunicato stampa
Il giardino che vediamo oggi è il risultato di un intervento degli anni ’30 del
secolo scorso e di una serie di successive integrazioni e casualità inclusa, a
partire dagli anni ’50, una manutenzione non coordinata che ha dato ampio spazio
ad iniziative spontanee motivate da questioni di urgenza e dalla disponibilità
fortuita di piante.
Il giardino rinascimentale è andato completamente perso e non ne abbiamo
documentazione. Sappiamo che si estendeva ad est del Palazzo, con giardini, una
stalla ed alcune fabbriche. Di esso non rimane che un piccolo brandello: i
terreni sono stati frazionati e venduti, modificandone poi la destinazione
d’uso.
Il Palazzo è stato per lunghi periodi abbandonato, causando ulteriori perdite e
mutilazioni.
Dalle indagini archeologiche è emerso che nell’attuale giardino a sud c’era un
muro di cinta che tagliava trasversalmente il giardino, con una porta di accesso
all’area esterna che era coltivata ad orto - frutteto. Il muro è stato demolito
verso la metà del 1800 mentre la destinazione d’uso ad orto è rimasta invariata
fino all’inizio del ‘900.
Verso gli anni ’30, in occasione del restauro del Museo, si procedette al
ridisegno del giardino dove ora si trova, a sud e ad est del Palazzo, una
ricostruzione immaginata di un giardino rinascimentale. Il disegno non si basava
sulle preesistenze ma era frutto di un’invenzione. Il progetto fu redatto da un
disegnatore tecnico, lo Stanzani, che, applicando con buona volontà le direttive
sulla ricreazione del giardino rinascimentale ferrarese che provenivano dai
dettami ministeriali, presentò molte soluzioni alternative.
Nel 1939 il giardino si presentava come una semplice compartimentazione a
riquadri che delineava le aiole contornate da bosso e ligustro, mantenendo le
direttrici dei percorsi ancora oggi esistenti, sia ad est che a sud.
A chiudere la prospettiva dell’entrata, i percorsi e i riquadri si concludevano
con esedre curve di ligustro, più alte per occludere la vista.
Il labirinto (e i giochi interni ai riquadri con le siepi in bosso) è stato
aggiunto all’interno dei riquadri inizialmente vuoti dopo gli anni ’50;
successivamente sono stati aggiunti i Cupressus Arizonica, i Tassi, le Thuie, i
Cercis e le Robinie ed è stata realizzata la galleria delle rose.
In questo modo si è progressivamente perso il disegno del giardino formale e si
è creato un sovraffollamento disordinato di arbusti ed alberature che ha
provocato la necessità di una manutenzione sempre maggiore proprio mentre veniva
progressivamente ridotta per questioni economiche. Risultato, una manutenzione
inadeguata in termini quantitativi. Il tutto aggravato dall’istallazione, in una
porzione del giardino sud, verso via Porta d’Amore, di imponenti impianti per il
condizionamento e dalla formazione di un accesso e di una rampa. Un nuovo
accesso ed una rampa venivano creati anche nel giardino ad est, da via XX
Settembre.
Anche i pozzi, risalenti ai primi dell’800, non sono originali e non
appartengono al luogo. Provengono entrambi da smembramenti di altre proprietà,
uno è originario di una casa Ferrarese e l’altro di una casa Veneziana, e sono
stati riposizionati dove si trovano tuttora. La loro posizione nel sito non
corrisponde a tracce antiche né si relaziona con il sistema di raccolta e
distribuzione dell’acqua.
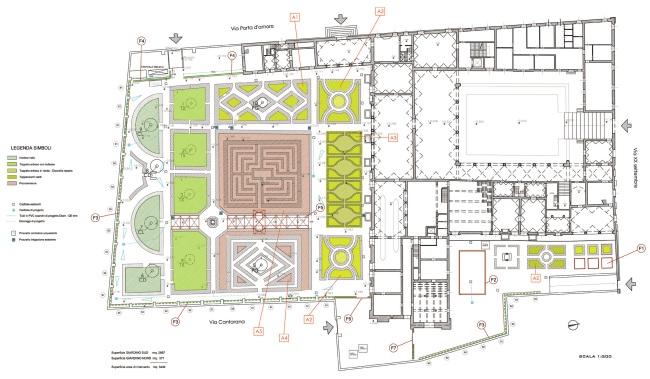
Il progetto di restauro elaborato dall'Arch. Maria Luisa Mutschlechner in
collaborazione con l'Arch. Matteo Pernigo
Il progetto di restauro del giardino è stato elaborato con rara sensibilità e
competenza dall’architetto Maria Luisa Mutschlechner (Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Roma) con la collaborazione di molti
specialisti e il contributo dell'Arch. Matteo Pernigo dello Studio Associato PanGEA di Padova.
Il notevole lavoro di studio, ricerca, indagine ed analisi, indispensabile
all’intervento di restauro, ha restituito un quadro esaustivo della storia e
dello sviluppo del giardino.
Indagini archeobotaniche e palinologiche, curate da Marco Marchesini,
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, e Silvia Marvelli,
Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" di San Giovanni in Persiceto
(Bologna), hanno restituito interessanti dati sulle specie vegetali presenti
nell’area nel corso dei secoli.
Studi agronomici condotti da Giovanni Morelli, grazie ad una convenzione di
collaborazione con il Comune di Ferrara (che ha anche sostenuto le relative
spese), hanno consentito di ricostruire un quadro completo dello stato
vegetazionale e agronomico.
Saggi archeologici condotti da Maurizio Molinari hanno restituito nuovi
importanti dati e conferme sulle strutture antiche e sugli impianti storici.
Non possiamo dimenticare, infine, l’impegno dell’Istituto Tecnico Agrario “F.lli
Navarra” di Ferrara che ha clonato il bosso originale per mettere a disposizione
nuove piante da impiegare nella integrazione delle siepi.

Messa a dimora delle talee di bosso da parte degli allievi dell'Istituto Tecnico
Agrario “F.lli Navarra” di Malborghetto di Boara (FE)
Il progetto di restauro del giardino
Il restauro non può ricreare qualcosa che non è mai esistito. La teoria e la
pratica della conservazione sono finalizzate a tramandare le cose, così come ce
le consegna l’accidentalità della concatenazione dei fatti: in caso contrario si
andrebbe a falsificare ciò che è realmente accaduto.
L’intervento proposto si configura in realtà come una manutenzione conservativa
che tiene conto sia dei materiali archeologici sottostanti la superficie, che
delle conseguenze dei restauri congetturali degli anni Trenta e di alcune
modifiche ed integrazioni apportate negli anni seguenti.
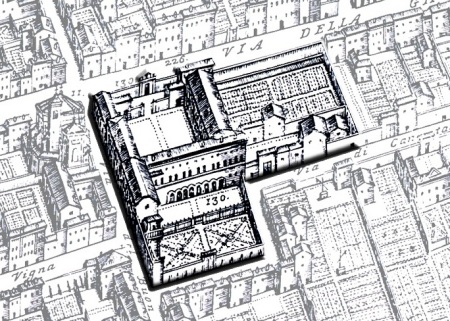 Sarà mantenuta la struttura ed il disegno attuale delle siepi e dei percorsi, e
saranno mantenuti anche alcuni elementi aggiunti come il labirinto e la galleria
di rose, considerati ormai elementi caratterizzanti questo giardino.
Sarà mantenuta la struttura ed il disegno attuale delle siepi e dei percorsi, e
saranno mantenuti anche alcuni elementi aggiunti come il labirinto e la galleria
di rose, considerati ormai elementi caratterizzanti questo giardino.
Saranno mantenuti anche i Cedri Deodara e del Libano che si trovano verso il
confine sud, al momento oggetto solo di un intervento di rimonda del secco ed
innalzamento della chioma.
Il progetto mira a riordinare e ripulire il giardino a partire dalle molte
piante infestanti, arbusti ed alberi che sono assolutamente ad di fuori di un
ordine formale.
Saranno abbattuti anche quegli alberi, come gli abeti, che rappresentano un alto
rischio di crollo o di cedimento di rami, come già avvenuto lo scorso inverno.
Il giardino sarà ripulito anche da altri elementi di disturbo e dai vari
materiali depositati negli anni.
Il labirinto e in generale tutte le siepi in bosso saranno conservati con
interventi puntuali di ricucitura, mediante integrazione e sostituzione delle
fallanze con gli esemplari degli anni ’30 clonati dall'Istituto Navarra.
La galleria di rose sarà mantenuta ma si procederà alla sostituzione della
struttura in ferro -realizzata in economia, con materiali di recupero- con una
nuova struttura che avrà un disegno semplice e una forma analoga all’esistente.
Ove possibile si manterranno le attuali rose, integrandole se necessario con
nuove varietà.
Gli attuali quattro tassi saranno riposizionati al centro dei riquadri oltre il
pozzo, per migliorare la vista prospettica dal portico d’entrata e la lettura
del disegno delle siepi.
Lo spostamento dei Tassi è dovuto anche a problemi archeologici. L'intervento
mira a tutelare una struttura muraria rinvenuta nel giardino sud, a circa 1
metro di profondità, evitando ulteriori danni alla costruzione di cui rimane,
oltre al fondamento, anche piccole porzioni di alzato (decorato a cortina
dipinta)
Al centro dei riquadri delle siepi laterali, dove si trovano una Thuia ed una
Magnolia, si prevede la piantumazione di due alberi di Melograno, pianta già
presente nel giardino e tipica dei giardini rinascimentali.
Le aiole saranno migliorate nel modellamento; per potenziare gli scoli,
all'interno dei riquadri saranno piantate specie erbacee, tappezzanti e bulbose
fiorite per creare una copertura stabile e non invasiva del piano sottostante,
utilizzando specie con radici superficiali. L’intenzione è creare superfici
cromaticamente uniformi e fiorite, che sottolineino con la loro diversità il
disegno delle siepi.
I livelli del terreno sono stati modificati in più riprese nel tempo. Il
progetto prevede di intervenire con una sistemazione superficiale del suolo,
apportando dei correttivi di minima alle attuali pendenze per migliorare gli
scoli. A tal fine saranno creati drenaggi e nuovi punti di raccolta e deflusso
delle acque meteoriche
I percorsi nel giardino, che oggi presentano avvallamenti e profili irregolari,
saranno regolarizzati e rifiniti in stabilizzato pressato e rullato, in modo da
essere percorribili anche da persone anziane e/o disabili.
Il muro di cinta, modificato e ricostruito nella parte superiore nel corso del
tempo, sarà rivestito con piante rampicanti fiorite -quali Rose, Hydrangee,
Clematis armandii e viti americane- che cresceranno su idonei grigliati in
ferro. Tali strutture saranno di fattura analoga a quella della galleria delle
rose. Il sistema dei grigliati avrà anche una funzione schermante e servirà a
mascherare gli impianti di condizionamento e a creare delle compartimentazioni
fra il giardino sud, l’area di carico e scarico del museo ed il giardino est.
Per quanto concerne l’aspetto degli impianti, allo stato attuale esiste un
sistema di irrigazione non funzionate ed un pozzo artesiano che risulta non
essere mai stato messo in funzione. L’intervento prevede la messa in funzione di
questo pozzo e la realizzazione di un nuovo impianto automatico di irrigazione a
goccia e con irrigatori statici. Si prevede infine di realizzare le opere
necessarie per la predisposizione di un impianto di illuminazione notturna del
giardino.
Ricostruzione del paesaggio vegetale e dell’ambiente circostante Palazzo
Costabili, detto “di Ludovico il Moro”
I Dottori Marco
Marchesini, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, e
Silvia Marvelli, C.A.A. Giorgio Nicoli,
Sede di S. Giovanni in Persiceto, hanno eseguito una serie di analisi
archeobotaniche e palinologiche dai risultati in gran parte sorprendenti.
Riportiamo di seguito una sintesi della loro relazione che ha suscitato grande
interesse tra gli addetti ai lavori.
L’archeologia del paesaggio è una tematica sempre più ricorrente nella
letteratura storica e archeologica degli ultimi decenni. Essa collega l’uomo
all’ambiente in cui vive, associando due ambiti sempre più inscindibili l’uno
dall‘altro: fin dalle epoche più antiche l’insediamento antropico è condizionato
dal paesaggio vegetale che, a sua volta, viene continuamente modificato dalle
attività dell’uomo. Da qui la necessità di ricostruire il paesaggio antico
incrociando i dati archeologici a quelli di altre discipline quali la
geomorfologia, la sedimentologia, la climatologia, la pedologia, l’archeobotanica
e l’archeozoologia.
Le indagini palinologiche consentono non solo di ricostruire l’evoluzione del
paesaggio vegetazionale e ambientale di un determinato luogo, ma anche di
individuare le varie attività dell’uomo nel corso del tempo, scoprendo ad
esempio quali piante coltivava e/o raccoglieva, quali utilizzava e per quale
scopo, quali attività esercitava su una determinata area (es. ceduazione dei
boschi, vinificazione, trebbiatura) o ancora, segnalano la presenza di aree
boscate oppure di zone umide, di prati/pascoli o di canali/fossati, ecc.,
informazioni fondamentali per meglio inquadrare il substrato, il clima,
l’orografia e la topografia di un determinato contesto. Questi studi rendono
inoltre possibile ricostruire importanti aspetti dell’alimentazione umana, degli
scambi commerciali, dell’utilizzo medicamentoso e fitoterapico di alcune piante,
delle offerte votive legate ai riti religiosi e funerari, ecc.
Questo contributo presenta i risultati dell’analisi palinologica di sei campioni
prelevati da diversi sondaggi nell’area del giardino di Palazzo Costabili detto
“di Ludovico il Moro”, attuale sede del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.
I campioni di sedimento sottoposti ad analisi palinologica sono stati prelevati
dall’archeologo Maurizio Molinari in sondaggi effettuati in diverse zone del
giardino.

Fasi del campionamento pollinico sotto i cedri del giardino di Palazzo Costabili
I risultati delle indagini palinologiche consentono di ricostruire la storia del
contesto vegetale che si è avvicendato nel corso del tempo all’interno
dell’attuale giardino: il paesaggio vegetale antecedente il Giardino era
alquanto deforestato e caratterizzato da un ambiente molto aperto e con costanti
ed evidenti segni delle attività dell’uomo.
Le piante legnose non raggiungono mai il 17% e sono sempre fortemente in
sottordine rispetto alle piante erbacee. Gli Alberi+Alberi/arbusti costituiscono
la componente maggiore, mentre decisamente meno rappresentati risultano gli
arbusti
Più ricca e diversificata è la componente erbacea, predominante in tutti i
campioni esaminati. Nel complesso le Erbacee sono rappresentate soprattutto da
Graminacee, sia spontanee che coltivate.
Gli Indicatori Antropici sono costituiti da piante la cui presenza è
direttamente e strettamente collegata alle attività dell’uomo perché coltivate
oppure perché vivono in ambienti creati dall’uomo o direttamente ad esso
collegati.
Vengono di seguito descritti i contesti vegetazionali emersi dalle indagini
polliniche suddivisi in ambiti cronologici.
IL PAESAGGIO VEGETALE E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE PALAZZO COSTABILI A META’ DEL
XV SECOLO
Il contesto vegetazionale descrive un ambiente decisamente molto aperto con
presenza di rare alberature; sono presenti orti di medie dimensioni alternati ad
aree abbastanza ampie a prato o terreno lasciato incolto. Sono inoltre
documentate diverse specie tipiche di ambienti umidi, probabilmente a
testimonianza di un impianto idraulico di una certa consistenza nei pressi
dell’area del Palazzo. Sono state rinvenute anche diverse Pteridofite,
probabilmente localizzate nell’area vicina all’impianto idraulico. Si segnala
infine la rilevante concentrazione dei cereali, rappresentati in prevalenza da
orzo e grano, che può indicare sia la loro coltivazione in aree circostanti il
Palazzo, sia operazioni di trasporto o di carico/scarico delle granaglie per
essere immagazzinate/lavorate.
IL PAESAGGIO VEGETALE E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE PALAZZO COSTABILI TRA FINE XV
E INIZIO DEL XVI SECOLO
Pressoché simile risulta il paesaggio vegetale emerso dall’analisi dei
campioni di questa fase: il contesto vegetazionale rimane nettamente aperto, con
presenza di alcuni alberi da frutto fra cui Ciliegio e Vite. Prevale sempre la
componente erbacea testimoniata da orti di medie dimensioni alternati ad aree a
prato più o meno ampie, parte delle quali potrebbero essere costituite dai
camminamenti posti fra un orto e l’altro. Si segnala una leggera riduzione delle
attività legate ai cereali.
Anche se in calo rispetto alla fase precedente, sono ancora documentate diverse
specie tipiche di ambienti umidi, soprattutto idro-elofite erbacee, a
testimonianza, come per la fase precedente, della permanenza di un impianto
idraulico nei pressi del Palazzo. Si contraggono anche le Pteridofite.
IL PAESAGGIO VEGETALE E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE PALAZZO COSTABILI A META’ DEL
XVI SECOLO
Nel complesso, il quadro vegetazionale emerso dalle analisi di questi
campioni descrive un ambiente decisamente simile negli aspetti generali a quello
già evidenziato nelle fasi precedenti, ovvero un contesto intorno al Palazzo
decisamente aperto, con ampie zone a prato e a incolto e con rare alberature.
Sembra invece mutare l’assetto dell’area relativo agli orti e alle zone
destinate alla coltivazione/lavorazione delle granaglie, che in questa fase si
riducono fortemente. Ritorna più consistente la componente delle piante tipiche
di ambienti umidi, sia delle igrofite arboree che delle igro-idro-elofite
erbacee a cui si accompagnano anche le Pteridofite, a testimonianza della
presenza di vasche/impianti idraulici attivi in questa fase nei pressi del
Palazzo. Si segnala infine una riduzione degli Indicatori Antropici Spontanei,
probabilmente dovuto ad una maggiore cura e manutenzione dell’area circostante
il Palazzo da parte dell’uomo.
CONCLUSIONI
 Il contesto vegetazionale emerso dalle analisi polliniche eseguite durante i
sondaggi archeologici effettuati nel Giardino di Palazzo Costabili descrivono un
ambiente decisamente molto aperto con presenza di rare alberature in tutte le
fasi esaminate. Prevale sempre la componente erbacea testimoniata da numerose
specie antropiche: particolarmente significativo il rinvenimento di numerose
ortive che attesterebbe la presenza di orti di medie dimensioni dove venivano
coltivate varie piante quali Chenopodiacee con rape e bietola da costa,
Crucifere (iberidella e senape), Composite (cicoria comune -nella foto- e
lattuga), menta e numerose Umbellifere fra cui aneto puzzolente, angelica
arcangelica, ecc. Inframmezzati agli orti vegetavano anche diverse piante da
frutto quali Vite, Noce e diversi Pruni fra cui anche il Ciliegio. E’ possibile
che all’interno di questi orti fossero presenti anche arbusti quali Erica ed
Eliantemo.
Il contesto vegetazionale emerso dalle analisi polliniche eseguite durante i
sondaggi archeologici effettuati nel Giardino di Palazzo Costabili descrivono un
ambiente decisamente molto aperto con presenza di rare alberature in tutte le
fasi esaminate. Prevale sempre la componente erbacea testimoniata da numerose
specie antropiche: particolarmente significativo il rinvenimento di numerose
ortive che attesterebbe la presenza di orti di medie dimensioni dove venivano
coltivate varie piante quali Chenopodiacee con rape e bietola da costa,
Crucifere (iberidella e senape), Composite (cicoria comune -nella foto- e
lattuga), menta e numerose Umbellifere fra cui aneto puzzolente, angelica
arcangelica, ecc. Inframmezzati agli orti vegetavano anche diverse piante da
frutto quali Vite, Noce e diversi Pruni fra cui anche il Ciliegio. E’ possibile
che all’interno di questi orti fossero presenti anche arbusti quali Erica ed
Eliantemo.
L’elevata presenza di cereali, in particolare nella fase iniziale della serie,
potrebbe documentare sia la loro coltivazione in aree circostanti il Palazzo,
sia l’esistenza non lontano dal Palazzo di un’area destinata alla lavorazione
del grano o dell’orzo oppure di un edificio in cui venivano effettuate
operazioni di scarico ed immagazzinamento delle granaglie.
La buona presenza del gruppo delle Graminacee spontanee accompagnate dalle
Cicorioidee documenta l’esistenza di aree di medie dimensioni destinate a
prato/incolto soggette a calpestio presenti nelle immediate adiacenze dell’area.
Alcune di queste zone potevano costituire i camminamenti posti fra un orto e
l’altro.
Sono inoltre documentate diverse specie tipiche di ambienti umidi, soprattutto
idro-elofite erbacee, che segnalano un impianto idraulico di una certa
consistenza nei pressi del Palazzo.
La copertura arborea rimane sempre sullo sfondo del paesaggio: prevalgono le
Latifoglie Decidue con numerose specie tipiche del Querceto planiziario quali
Quercus caducifoglie e in particolare Farnia, Roverella accompagnate da Carpini,
Nocciolo, Frassini e Olmo. Risultano invece in sottordine le Conifere, che sono
rappresentate prevalentemente da Pini e da Abete bianco, presente in tracce. E’
plausibile pensare che qualche pianta arborea sia di Latifoglie Decidue che di
Conifere potesse vegetare anche nell’area circostante il Palazzo, anche se le
specie rinvenute fanno più propendere per apporti provenienti da aree boschive e
collinari/montane per le Conifere, soprattutto per la prima e la seconda fase.
ULTERIORI ANALISI POLLINICHE
Il contesto vegetazionale emerso dalle ulteriori analisi polliniche eseguite
con carotaggi nel Labirinto e presso il muro perimetrale del Giardino di Palazzo
Costabili descrive un ambiente sempre decisamente aperto nell’area del labirinto
con presenza di rare alberature costituite da Latifoglie Decidue e specie
sempreverdi fra cui varie Cupressacee e Pini accompagnati da siepi di Bosso e
Alloro. Nei campioni del Labirinto prevale sempre la componente erbacea,
testimoniata da pollini riferibili al gruppo delle Graminacee spontanee
accompagnate a diverse Composite fra cui in prevalenza Cicorioidee che,
accompagnate alla Graminacee, documentano aree di medie dimensioni destinate a
prato.
Nel campione basale della carota al centro del labirinto risulta rilevante la
presenza di specie tipiche di ambienti umidi e, in particolare, di igro/idrofite
a testimonianza dell’esistenza di una struttura con acqua permanente in tutti i
periodi dell’anno.
Nel campione 1 e 2 sono state rinvenute varie specie ortive che attesterebbero
la presenza di zone ad orti di medie dimensioni dove venivano coltivate varie
piante quali rape e bietola da costa, Crucifere (iberidella e senape), cicoria
comune, menta e numerose Umbellifere fra cui aneto puzzolente, angelica
arcangelica, ecc. come risulta anche nei precedenti campioni analizzati dei
livelli archeologici.
Nell’area vicino al muro perimetrale si verifica un incremento di specie arboree
ornamentali sempreverdi (Pini, Cedri e diverse Cupressacee con Cipressi e Thuie)
accompagnati da Latifoglie sempreverdi quali Bosso e Ligustro. Rimane costante
la presenza di zone lasciate a prato; si segnala la rilevante presenza di
Pteridofite, soprattutto Felci, che potrebbero essere state impiegate come
specie ornamentali.

Fasi del campionamento pollinico nel labirinto del giardino di Palazzo Costabili
Informazioni:
Direttore Lavori, Arch. Matteo Pernigo
Responsabile del procedimento, Arch. Andrea Sardo
Analisi archeobotaniche e palinologiche,
Dott. Marco Marchesini e
Dott.ssa Silvia Marvelli
Pagina a cura di Carla Conti